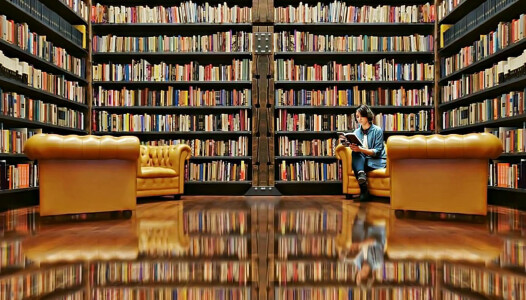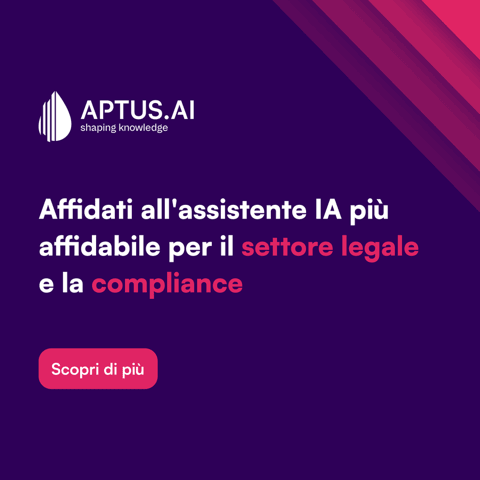Perché ho introdotto la disciplina della Scienza della complessità come materia fondamentale nella disciplina della Compliance aziendale e della Governance
Cominciamo a capire che la scienza della complessità studia i sistemi in cui un gran numero di componenti o sottosistemi, a volte di natura diversa, si combinano per produrre fenomeni emergenti sorprendenti evidenti su scale multiple, e questo è esattamente quanto è qualsiasi organizzazione.
Sono questi fenomeni, nascosti dietro le regole spesso apparentemente semplici ed elementari che governano i singoli componenti, che meglio definiscono i sistemi complessi.
Poiché questi comportamenti di interesse derivano dalle interazioni tra le parti che a loro volta sono le persone presenti in una azienda, le condizioni dell’ambiente esterno all’impresa, le persone che interagiscono a monte e a valle di questa, i sistemi complessi non sono controparti di sistemi semplici o complicati come riduzionisticamente vengono intesi, ma piuttosto un interagire dinamico fra questi.
Il loro studio quindi richiede un approccio su scale e ambiti disciplinari diversi. Tuttavia, questo approccio introduce sfide nel modo in cui tradizionalmente si affrontano le realtà aziendali, ovvero occorre non solo dichiarare una compliance trasversale ma capire la scienza della complessità, che spesso non rientra nelle riviste disciplinari se non come aggettivo.
L’idea di complessità come sguardo transdisciplinare ai sistemi è già di per sé un fenomeno emergente in quanto non può essere ricondotta a una singola azienda, singolo individuo, studio, norma di legge o evento, ma è invece un fenomeno che abbraccia tutti i campi. Nella sua definizione più ampia, la complessità è una prospettiva che abbraccia l’incertezza e la necessità di multidisciplinarietà a fronte di grandi sistemi interconnessi quali sono i mercati.
Già in René Descartes nella “Le passioni dell’anima” del 1649, la vita umana stessa è descritta come molte parti di natura diversa che interagiscono creando reti con proprietà emergenti dove gli effetti locali possono avere conseguenze globali sorprendenti, ma questa intuizione fu usata per cercare di combattere idee complesse che sfidano le descrizioni riduzioniste e le semplificazioni della realtà in logica causa effetto lineare, quelle che ancora oggi sono alla base delle teorie di management e di come si affronta la governance e la compliance.
Dobbiamo attendere il 1962 con Herbert Simon quando tracciò delle linee guida per lo studio dei sistemi complessi in “L’architettura della complessità”, scienziato dedito alla ricerca sull’organizzazione e sull’intelligenza artificiale.
Un decennio dopo il fisico Philip W. Anderson si scontrò con l’ipotesi riduzionista standard con “More Is Different: Broken symmetry and the Nature of the Hierarchical Structure of Science” dove sostiene la necessità di molteplici prospettive poiché “ la capacità di ridurre tutto a semplici leggi fondamentali non implica la capacità di partire da quelle leggi e ricostruire l’universo ” e questo è scomodamente vero quando si pretende, con singoli interventi o la sola enunciazione di queste, di far rispettare norme e leggi ad un sistema complesso quale è ogni azienda o organizzazione, e su scala più ampio un’intera nazione.
Idee simili sono emerse anche in filosofia con il lavoro transdisciplinare di Edgar Morin e le sue critiche alla teoria riduzionista o sistemica con “Introduzione à la pensée complexe”.
Oggigiorno le reti di interazione di qualsiasi genere come quelle delle organizzazioni e nelle aziende vengono analizzate nella logica della scienza della complessità, dallo studio delle epidemie e della comunicazione e del comportamento collettivo, così per la disinformazione. Questo dialogo tra le discipline e questa ricerca di modelli e teorie unificati divennero l’etica della scienza della complessità nei decenni successivi.
La complessità non è una scienza di per sé, ma è certamente un insieme di discipline diverse con un approccio condiviso ed oggi è ha trovato una sua collocazione chiave anche nella disciplina della Compliance dato che tratta di:
- come fare auto emergere un comportamento compliance dall’insieme delle interazioni delle persone (agenti) che compongono un’organizzazione e di questa nelle interazioni con il mercato e la società (ambiente esterno).
La scienza della complessità ci aiuta a comprendere meglio noi stessi attraverso modelli complessi del nostro cervello. Uno dei fattori trainanti di questa disciplina è il messaggio fondamentale “di più è diverso”. In tutte le discipline, passare da un sistema ideale studiato in isolamento a una popolazione aperta che interagisce quale è una organizzazione è estremamente difficile. Recentemente abbiamo celebrato il premio Nobel di Giorgio Parisi che ha sottolineato l’importanza di lasciare che la curiosità e la serendipità del mondo reale guidino anche l’indagine scientifica teorica e fondamentale ed a maggior ragione si adotti questo approccio globale all’analisi e alla gestione delle organizzazioni.
La ricerca che trascende i confini disciplinari rompendo con gli approcci tradizionali verticistici adottanti in campo compliance deve affrontare sfide uniche nel sistema consulenziale tradizionale, che è costruito su rigide basi disciplinari.
Attualmente, la Compliance improntata sulla complessità si trova spesso a dover operare in un contesto fortemente riduzionistico, basato su logica causa effetto lineare e che ritiene che gli esseri umani siano dotati di razionalità assoluta e che una volta edotti su come debbano agire rispondano come gli ingranaggi di un macchinario.
Nulla di più errato! Qualsiasi spiegazione di una norma o di una legge fatta in astratto, separata dal contesto e dall’ambiente, fornite delle check list di controllo, un sistema sanzionatorio e coercitivo, è illusorio che possa rendere compliant quell’aggregato. Le persone interagiscono fra loro e con l’ambiente. Una organizzazione:
- non è mai un sistema separato o isolato
- né è stabile nel tempo ma
- muta continuamente, e come tutti i sistemi complessi dinamici
- non è predicibile nel suo comportamento, se non per aspetti molto marginali, pertanto ogni criterio gerarchico formale è solo un ansiolitico che ci illude di ottenere certi comportamenti conformi a qualche serie di regolette formali ma certamente non è in compliance.
La scienza della complessità è a volte descritta come unica, ma ha al suo interno molte altre discipline a supporto, come la teoria dei sistemi, la cibernetica, l’ecologia, le scienze politiche e qualsiasi altro campo interessato a sistemi composti da molte parti che interagiscono su più scale o attraverso meccanismi diversi. Il valore dell’uso del termine “complessità” sta nella sua identità sfumata, complessità non è un aggettivo.
A queste discipline tipiche del campo della Compliance ho dovuto introdurre i concetti e le nozioni della neurologia comportamentale, dato che si tratta di sistemi composti da soggetti umani (dotati di razionalità limitata) che interagiscono fra loro e con l’ambiente esterno, pertanto i meccanismi alla base delle interazioni comportamentali sono spiegate dalla neurologia comportamentale , e si badi bene di non confonderla con la psicologia.
Per i motivi sin qui esposti c’è un disperato bisogno di un approccio olistico alla ricerca sulla Compliance: dalla teoria, agli esperimenti, alle applicazioni, compresa la filosofia e l’etica di singoli e degli aggregati sociali. Fra le discipline da usare troviamo ad esempio anche :
- scienza delle reti,
- vita artificiale,
- scienze sociali computazionali,
- biologia dei sistemi,
- scienza dei dati,
- ecologia ed evoluzione,
- sistemi dinamici,
- economia e finanza,
- e complessità sociale.
Spaziando attraverso questi ambiti e altri ancora, scopriamo che i problemi più urgenti che l’umanità e a maggior ragione gli aggregati come le organizzazioni devono affrontare sono di natura interdisciplinare così come lo sono: pandemie emergenti, disinformazione, cambiamento climatico, crescente disuguaglianza globale, movimenti per i diritti umani, adattamenti alle nuove tecnologie e le interazioni non lineari che emergono tra tutte queste sfide.
Nessuno di questi problemi può essere affrontato isolatamente, essi richiedono un pensiero complesso o pensiero sistemico, e discipline che consentano di superare le logiche sino ad oggi ed ancora usate nel campo della compliance. Occorre imparare a percepire i sistemi nel loro complesso e le loro interazioni, imparare a ragionare secondo la logica causa effetto circolare, abbandonare il riduzionismo, i modelli mentali basati su comportamenti razionali e meccanicistici, in un certo senso ogni organizzazione, così come ogni sistema complesso, fa storia a sé e, per affrontarle occorre imparare, in un certo senso, quello che è detto in altri abiti a ragionare secondo il pensiero divergente. Il pensiero divergente emerge in modo spontaneo, a flusso libero, non lineare ma multidirezionale perché non ordina le opzioni già esistenti e le tassonomie ma ne scopre di nuove e crea idee alternative in un tempo molto breve facilitando l’adattamento continuo alla mutevolezza dei sistemi complessi.
“Il modo migliore per avere una buona idea è avere molte idee” (Linus Pauling).
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
H. A. Simon, (1962), The Architecture of Complexity
P. W. Anderson, (1972), More Is Different. Broken symmetry and the nature of the hierarchical structure of science
E. Morin, (1992), From the concept of system to the paradigm of complexity
M. Mitchell, (2009), Complexity: A Guided Tour, Oxford University Press
G. Parisi, (2023), In a Flight of Starlings: The Wonders of Complex Systems, Penguin Press
S. A. Kauffman, (1993), The Origins of Order: Self-organization and Selection in Evolution (Oxford University Press)
M. Mitchell, (2009), Complexity: A Guided Tour (Oxford University Press)
M. Newman, (2018), Networks (Oxford University Press)