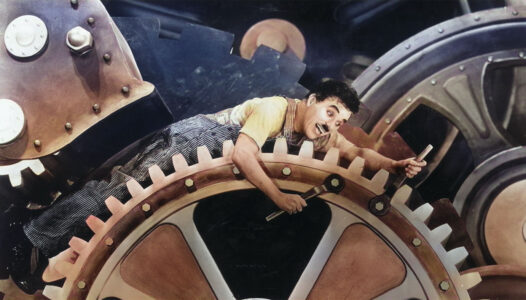di Michela BOI
1. Datore di lavoro: oltre la qualifica formale, la sostanza del ruolo
Nel quadro normativo nazionale in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro è il fulcro dell’organizzazione prevenzionistica, in quanto soggetto primariamente responsabile della gestione del rischio e dell’attuazione delle misure di protezione in azienda.
L’art. 2087 del codice civile(1) attribuisce infatti all’imprenditore l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori, in ossequio al potere organizzativo e direttivo che l’ordinamento gli riconosce ex artt. 2086(2) e 2094(3) c.c. È da questa correlazione tra potere e responsabilità che discende la posizione di garanzia propria del datore di lavoro: egli è colui che ha la possibilità concreta di governare i fattori di rischio e porre in essere le misure prevenzionistiche necessarie.
Di conseguenza, risponde degli eventi lesivi che derivino da un esercizio inadeguato di tale potere-dovere.
In tale prospettiva, si rende imprescindibile una corretta individuazione del soggetto che, in via sostanziale, riveste il ruolo di datore di lavoro responsabile della gestione della sicurezza dei lavoratori.
Alla luce della crescente complessità del sistema imprenditoriale, caratterizzato da una progressiva articolazione di strutture e funzioni e da un significativo decentramento di compiti e competenze, l’individuazione dei centri di responsabilità non può più fondarsi su meri criteri formali. È invece necessario adottare un approccio sostanzialistico, orientato alla verifica della concreta titolarità di poteri decisionali, gestionali e di intervento in materia di prevenzione.
Nel prosieguo si tenterà di delineare alcuni criteri guida utili a orientare tale processo ricostruttivo, tenendo conto dell’attuale assetto delle organizzazioni aziendali.
Il punto di partenza è rappresentato dall’art. 2, co. 1, lett. b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – TUSL), il quale definisce datore di lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva(4) in quanto esercita poteri decisionali e di spesa”.
La norma in esame identifica quindi il primo destinatario degli obblighi prevenzionistici, delineando, in via alternativa:
- un criterio formale (titolarità del rapporto di lavoro);
- un criterio sostanziale (la titolarità e l’esercizio effettivo dei poteri decisionali e di spesa in relazione all’intera organizzazione o a una sua unità produttiva).
Tale doppio criterio – formale e sostanziale – riflette l’intento del legislatore di ancorare l’individuazione del garante non solo al ruolo giuridico-formale, ma anche all’effettiva assunzione ed esercizio dei poteri direttivi tipici del datore di lavoro, attribuendo prevalenza al dato contenutistico su quello formale.
A rafforzare tale prospettiva interviene l’art. 299 del TUSL, che riconosce la posizione di garanzia anche a chi “pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici” tipici del datore di lavoro. Si afferma così il principio di effettività: non conta solo il titolo formale, ma l’esercizio sostanziale del potere; il “fatto” (sostanza) prevale sulla “forma” (carica attribuita). Nello stesso senso, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione: “l’individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono quindi rispetto alla carica attribuita al soggetto” (Cass. Pen., sez. IV, 24 maggio 2022, n. 20127). In altri termini, al di là del mero criterio formalistico dell’individuazione dei soggetti collocati in una posizione di garanzia, al fine di identificare i centri di imputazioneoccorre, quindi, seguire un criterio sostanzialistico, e cioè stabilire i soggetti che, nel concreto, essendo dotati dei relativi poteri, sono venuti meno agli obblighi funzionali ad impedire l’evento infortunistico (Cass. Pen., sez. IV, 2 agosto 2024, n. 31665).
Questa impostazione si traduce nella possibilità di imputare obblighi e responsabilità anche ai c.d. soggetti di fatto, che – seppure formalmente privi della qualifica datoriale – assumono un ruolo apicale nell’organizzazione della sicurezza. Il riconoscimento della responsabilità del soggetto “di fatto”, tuttavia, non comporta un esonero automatico dei doveri di sicurezza e delle responsabilità del datore di lavoro “di diritto”. Sul punto, è ormai costante, infatti, l’orientamento giurisprudenziale che riconosce una responsabilità concorrente tra il soggetto investito formalmente della posizione di garanzia e colui che la esercita in via sostanziale. A riguardo, si veda Cass. Pen., sez. IV, 24 luglio 2023, n. 31885 che chiarisce: “l’articolo 299 vale ad elevare a garante colui che di fatto assume e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente e del preposto, mentre non può essere invocato in funzione restrittiva degli obblighi che la normativa prevenzionistica assegna ai soggetti regolarmente investiti di tali poteri”. Anche in presenza di un ruolo meramente apparente, dunque, la posizione di garanzia del datore di lavoro “di diritto” permane “essendo invero configurabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 299 d.lgs. 81/08, la corresponsabilità del datore di lavoro e di colui che, seppur privo di tale investitura, ne eserciti in concreto i poteri giuridici (Cass. Pen., sez. IV, 12 dicembre 2023, n. 49296; v. anche Cass. Pen., sez. IV, 07.06.2022, n. 21863).
Alla luce di tale assetto, anche l’approccio interpretativo è sempre più orientato verso una lettura dinamica e funzionale delle posizioni di garanzia, nella consapevolezza che la moderna organizzazione del lavoro impone una distribuzione articolata delle responsabilità, coerente con la reale dislocazione dei poteri e l’esercizio effettivo delle funzioni.
2. Il sistema multidatoriale e il concetto di unità produttiva
Il modello tradizionale di organizzazione della sicurezza, fondato sulla figura di un unico datore di lavoro titolare della posizione di garanzia (modello mono-datoriale), si mostra talvolta inadeguato a garantire una protezione efficace in contesti aziendali complessi e articolati. In realtà imprenditoriali di grandi dimensioni o caratterizzate da una struttura policentrica, infatti, i compiti in materia prevenzionistica e le responsabilità proprie del datore di lavoro possono essere assolti anche da colui il quale, dotato di autonomia gestionale e decisionale, è responsabile di ambiti organizzativi ben definiti configurabili come unità produttive autonome (cfr. il citato art. 2, comma 1, lettera t(5). Sul punto, l’INPS, attraverso una serie di interventi interpretativi (circolari n. 172/2010, n. 9/2017 e n. 56/2017, nonchè con messaggio n. 1444 del 31 marzo 2017), ha ulteriormente chiarito la distinzione tra “unità operativa” e “unità produttiva”. La prima coincide con il luogo ove “viene svolta in maniera stabile l’attività lavorativa di uno o più dipendenti” ovvero la “sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità”; la seconda, invece, si identifica con “la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma” e che svolgano“un’attività idonea a realizzare l’intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa”; in altri termini “maestranze adibite in via continuativa”.
In tali configurazioni, appare evidente come l’accentramento delle responsabilità in capo a un solo datore di lavoro (modello mono-datoriale(6)) non sempre risulti sufficiente a garantire una tutela adeguata, rendendosi quanto più opportuno un assetto organizzativo che consenta la (co)esistenza di più figure datoriali, ciascuna titolare di poteri e responsabilità autonomi rispetto all’unità produttiva di riferimento. È proprio in tali casi che si prospetta un diverso modello di gestione della sicurezza, il c.d. sistema “multi-datoriale”, ossia una struttura articolata di poteri in cui coesistono e convivono nella medesima azienda una pluralità di datori di lavoro, riconosciuti quali garanti in quanto assumono – per l’effetto dei poteri esercitati – pieno controllo sui rischi dell’unità operativa che governano.
Tale impostazione è stata avvalorata anche dalla Suprema Corte che ha riconosciuto la possibilità di configurare una pluralità di datori di lavoro, distinguendo tra datore “apicale” (al vertice dell’organizzazione complessiva) e datori di lavoro che potrebbero definirsi “sottordinati” (ossia i responsabili delle unità produttive autonome), a condizione che questi ultimi siano effettivamente titolari di poteri decisionali e di spesa richiesti dall’autonoma gestione dell’unità produttiva stessa (Cass. Pen., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 32899). Per essi il ruolo datoriale non elide il vincolo gerarchico verso il datore di lavoro; tale vincolo, infatti, permane, ma si esprime con modalità che non intaccano i poteri di decisione e di spesa richiesti dalla autonoma gestione dell’unità produttiva.
3. Datore di lavoro “apicale” e “sottordinato”: il perimetro delle responsabilità
Il presupposto dell’architettura descritta è la precisa delimitazione dei perimetri di responsabilità: ciascun datore deve poter esercitare i poteri necessari per attuare gli obblighi prevenzionistici nella propria sfera di competenza, in un’ottica di effettiva autonomia; allo stesso tempo, il frazionamento della posizione di garanzia non può tradursi in una dispersione delle responsabilità, né in una deresponsabilizzazione complessiva del sistema. Ne consegue l’esigenza di un coordinamento costante tra i vari soggetti coinvolti, soprattutto in relazione alle aree di intersezione tra le rispettive sfere di controllo.
In quest’ottica, la distinzione tra i diversi perimetri di responsabilità datoriale si fonda sullo specifico profilo di rischio affidato a ciascun garante, il quale deve poterlo gestire con autonomia decisionale e operativa. Il datore di lavoro “sottordinato” è quindi destinatario di tutti gli obblighi normativi propri della figura datoriale, ma esclusivamente “entro la e in funzione della gestione della sicurezza nell’ambito dell’unità organizzativa affidatagli”(7).
In tale specifico contesto, quest’ultimo è quindi tenuto a:
i) effettuare la valutazione dei rischi specifici dell’unità produttiva che governa;
ii) redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
iii) nominare il R.S.P.P.;
iii) vigilare sul corretto operato dei lavoratori.
Con riguardo a tali aspetti, il datore di lavoro “apicale” non è gravato da un obbligo di vigilanza sull’operato del datore di lavoro “sottordinato”, in quanto quest’ultimo, nello svolgimento delle proprie funzioni (con autonomia decisionale e di spesa) è ab origine titolare effettivo di una posizione di garanzia in quanto destinatario diretto del precetto penale e, dunque, responsabile diretto degli aspetti prevenzionistici dell’unità produttiva cui è preposto(8).
Tuttavia, sul datore di lavoro “apicale” possono comunque gravare dirette responsabilità ogniqualvolta egli adotti scelte organizzative o gestionali tali da determinare un’ingerenza sulla sfera di autonomia del datore di lavoro “sottordinato” (come ad es. nel caso di determinazioni atte a limitare l’indipendenza economica del datore di lavoro dell’unità produttiva o comunque determinazioni che espongano a rischi l’incolumità fisica o la vita dei lavoratori o dei terzi(9).
In defintiva, l’organizzazione aziendale in forma societaria, specie se articolata in diverse sedi operative o produttive, costituisce un contesto paradigmatico per l’applicazione del modello multidatoriale. In tale assetto, la ripartizione delle responsabilità deve riflettere la concreta allocazione dei poteri gestori funzionali alla prevenzione dei rischi prevenzionistici e l’effettiva dimensione organizzativa dell’ente.
L’adozione di un siffatto modello datoriale non equivale a una frammentazione del sistema, ma ne rappresenta, al contrario, una razionalizzazione secondo criteri di efficienza, coerenza interna e adeguatezza funzionale. Esso non si configura soltanto come una facoltà organizzativa, ma talvolta, una vera e propria scelta strategica, che coinvolge direttamente la responsabilità dell’organo amministrativo. Quest’ultimo, infatti, è tenuto ad assicurare un assetto organizzativo adeguato rispetto alla natura e alla dimensione dell’impresa, anche – e soprattutto – nella prospettiva della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tale adeguatezza organizzativa implica una valutazione consapevole della struttura della governance, intesa non solo come strumento di gestione aziendale, ma anche come presidio di protezione dei diritti fondamentali dei soggetti esposti ai rischi lavorativi.
Intervento di Michela BOI, Avvocato, Studio Legale LP Avvocati. Società Partner con Risk & Compliance.

LP Avvocati è uno studio legale multidisciplinare di Roma.
Il Dipartimento di Compliance offre assistenza in materia di responsabilità da reato degli enti, anticorruzione, privacy, cybersecurity, salute e sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente, whistleblowing, indagini interne e diritto dello sport. Gli avvocati ricoprono anche il ruolo di docenti presso Università, pubbliche e private; ISPRA; Camera Penale e altri Enti oltre a partecipare periodicamente, quali relatori, a convegni nazionali e internazionali.
Lo Studio si avvale di tecnologie avanzate e di strumenti di intelligenza artificiale per prestazioni di alto livello.
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) Art. 2087 c.c. (Tutela delle condizioni di lavoro): “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
(2) Art. 2086 c.c. (Gestione dell’impresa): “L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
(3) Art. 2094 c.c. (Prestatore di lavoro subordinato): “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
(4) Con ciò intendendosi, come si avrà modo di approfondire, lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione dei servizi dotati di autonomia tecnico finanziaria e tecnico funzionale” (art. 2 lettera t) TUSL).
(5) V. nota 4.
(6) Ossia quel sistema “incentrato sulla frammentazione della posizione del garante originario del datore di lavoro prevenzionistico, nel senso che il soggetto designato datore di lavoro è distinto e prescinde dall’essere titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore”. L. E. Golzio “Il confronto tra monodatorialità e multidatorialità”, in “Diritto sulla sicurezza sul lavoro”, 22.09.2023.
(7) Cass. Pen., sez. VI, 8 gennaio 2021, n. 32899.
(8) R. Blaiotta, Diritto penale e sicurezza sul lavoro, p. 24 (2020) Torino, Giappichelli Editore
(9) E. Scaroina, La responsabilità penale del datore di lavoro nelle organizzazioni complesse, in Sistema Penale, p. 18.