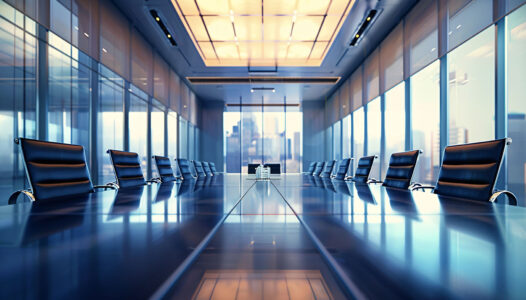di Cristiano ROMAGNOLI
Il fenomeno del “Earnings management” non rappresenta di per sé una novità nel mondo dell’economia aziendale, in quanto il suo studio da parte del mondo accademico inizia già nella seconda metà degli anni 70(1); è con alcuni recenti scandali societari e finanziari (limitatamente alla cronaca nazionale, giova ed esempio ricordare i casi di Cirio e Parmalat nelle annate 2001 – 2003) che lo stesso ha però generato un’attenzione sempre maggiore da parte degli studiosi.
Introduzione
Un fenomeno che non ha una definizione univoca e che ha stimolato parecchie riflessioni accademiche:
- Schipper(2) definisce il fenomeno dell’EM “un’intervento messo in atto volontariamente dai manager nella redazione dei documenti contabili attraverso il quale divulgare agli interlocutori esterni informazioni, con il solo intento di ottenere dei vantaggi privati per loro stessi” (una rappresentazione soggettiva e non neutrale dunque);
- Haely e Wahlen(3) invece scrivono dell’EM come “un utilizzo improprio della discrezionalità concessa ai manager nel modificare i report aziendali allo scopo, però, di ingannare gli azionisti sulla reale situazione economica della società o influenzare quei contratti e rapporti dipendenti dai dati registrati nel bilancio”;
- Verona(4) infine lo definisce come “il complesso di tutte le manovre contabili lasciate alla discrezionalità degli amministratori, che volontariamente le pongono in essere, e di tutte le operazioni ad hoc attuate per raggiungere uno scopo diverso dal fine economico ad esse sottostante”.
Rinviando alla letteratura sul tema, è verosimilmente corretto tradurre l’earnings management in una più semplice “gestione dell’utile”, attuata per il tramite delle cd. “politiche di bilancio”: un insieme di manovre, politiche e strategie utili a opacizzare il reale stato di salute dell’impresa.
Compreso dunque il significato etimologico dell’EM, la prima domanda che viene naturale porsi è: perché “manipolare” quel documento, ovvero il bilancio, che deve rappresentare la situazione aziendale in modo “chiaro, veritiero e corretto” (come richiesto dall’art. 2423 comma 2 del Codice civile)? Le risposte sono molteplici e, senza aver la presunzione di elencarle tutte, è possibile evidenziare quelle più “note”, ovvero:
- Retribuire maggiormente gli azionisti (posticipando i costi e/o anticipando i ricavi e dunque incrementando gli utili);
- Ridurre il monte imposte da pagare (posticipando i ricavi e/o anticipando i costi, così da ridurre il Profit Before Taxes e dunque la sua derivata prima, ovvero il risultato d’esercizio);
- Mascherare/posticipare lo stato di crisi aziendale;
- Migliorare il proprio merito creditizio, tanto per ottenere nuova finanza (agevolata e non), quanto per evitare la revoca di quanto già concesso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancato rispetto di covenants, downgrading di rating pubblici utili all’accesso delle relative garanzie, ecc.).
Scopo del presente non è approfondire le prime tre motivazioni (le quali vedono una letteratura accademica più che prolifica) ma piuttosto focalizzare l’attenzione sulla quarta: i cigni neri dell’ultimo quinquennio hanno stressato notevolmente gli attori del sistema banca – impresa, con le seconde che hanno fatto ampio ricorso al credito (spesso in modo poco ortodosso).
Politiche di Earnings Management e Principi Contabili
Si vedrà ora come il fenomeno dell’Earnings Management, prende forma e corpo con varie tecniche, le quali possono essere grossolanamente suddivise:
- In base alla tipologia di operazioni, ovvero politiche di:
- Real Earnings Management (le cosiddette operazioni di gestione);
- Disclosure Earnings Management (figlie della discrezionalità valutativa concessa dai principi contabili);
- In base alla condotta, ovvero politiche:
- Lecite (e dunque Real Earnings Management ed Accruals Earnings Management permesse dalla discrezionalità insita negli standard contabili);
- Fraudolente (ovvero falsi valutativi derivanti da operazioni di AEM in violazione degli standard contabili, e falsi documentali derivanti da fraudolent accounting, con logici ed inevitabili profili di rischio e reati penali).
Per comprendere ancora meglio la differenza tra le politiche, torna utile quanto teorizzato da Dechow P.M. e Skinner D.J.(5), i quali individuano tre “accounting choices” che non violano quanto disposto dai GAAP(6):
- Conservative accounting: un insieme di politiche particolarmente prudenziali finalizzate a comprimere gli utili (rispetto a quanto realizzato) e “rinviati” agli esercizi futuri; (es. politiche di accantonamenti particolarmente aggressive, sopravvalutazione delle spese di R&D post M&A, sovrastima degli oneri di ristrutturazione e delle svalutazioni di attività, posposizione delle vendite, incremento delle spese R&D, ecc.);
- Neutral earnings: ovvero quel reddito che deriva dalle cd. “operazioni neutrali” (non costituendo dunque earnings management);
- Aggressive accounting: ovvero politiche contabili molto aggressive finalizzate a massimizzare l’utile (es. attingere a riserve/accantonamenti in modo particolarmente aggressivo, sottostima degli accantonamenti per crediti di dubbia/difficile esigibilità, accelerare le vendite, riduzione delle spese R&D).
In contrapposizione a quanto sopra, gli autori classificano come “against GAAP” il fenomeno del Fraudolent Accounting, ovvero tutte quelle politiche contabili fraudolente e sanzionabili poiché in contrasto con gli standard contabili, quali ad esempio:
- Contabilizzazione delle vendite prima di quanto previsto dai principi contabili (completamento effettivo del processo di produzione, trasferimento dei rischi, della titolarità e dei benefici, ecc.);
- Falsa fatturazione;
- Retrodatazione delle fatture di vendita;
- Occultamento di passività;
- Sovrastima delle rimanenze e/o inventario fittizio.
Lasciando alla letteratura già presente la trattazione delle singole politiche di EM e prima di procedere, è doveroso fare un passo indietro, rimarcando l’enunciato (che tornerà utile nel proseguo) dell’art. 2423 comma 2 del Codice civile: “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.
Un altro riferimento codicistico sulla prudenza è quanto enunciato dal comma 2(7) dell’art. 2086, il quale cita testualmente che “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
Con la riforma della precedente Legge Fallimentare e l’avvento del nuovo Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII per brevità) il legislatore ribadisce la centralità della prudenza, tanto da richiedere all’imprenditore di dotarsi di tutti gli strumenti utili ad anticipare il potenziale “stato di crisi” (ovvero chiedendo un approccio “forward looking”, tipico del buon padre di famiglia che, forse più di tutti, incarna lo stesso concetto della prudenza).
La rappresentazione prudente dei fatti di gestione/contabili ex lege è quindi si necessaria per gli stakeholders, ma soprattutto per il ceto debitorio e per le banche: le seconde, in particolare, sono chiamate a valutare almeno annualmente (e conducendo nella prassi un monitoraggio trimestrale) i documenti contabili (e non) forniti dalle imprese clienti e/o richiedenti al fine di:
- Rinnovare gli affidamenti e le linee di credito in essere;
- Concedere nuova finanza che, soprattutto nella forma del medio lungo termine, drena molto capitale (perché il rischio, come l’interesse, sono funzioni del tempo) e necessita di un supporto ai fini del capital saving.
Eviscerato il concetto della prudenza e assodata la sua importanza (tanto nella gestione aziendale, quanto nella redazione del bilancio e nella sua valutazione), è possibile elencare alcune delle politiche di EM potenzialmente utilizzabili (attenzione, non necessariamente frodatorie!), nonché i principi contabili internazionali/nazionali coinvolti, per comprendere meglio il fenomeno ed i suoi impatti:
| STANDARD SETTER | POLITICA DI EM |
| OIC 11/IAS 1 – Finalità e postulati del bilancio d’esercizio | Mancata contabilizzazione di un fatto che non risponde al vero (fraudolent accounting) |
| OIC 13/IAS 2 – Rimanenze | Sopravvalutazione rimanenze, cambiamento discrezionale dei metodi di valutazione del magazzino, |
| OIC 15/IFRS 9 – Crediti/Strumenti finanziari | Mancata svalutazione dei crediti, sovra/sottostima del rischio di credito, mancata cancellazione di crediti fittizi |
| OIC 16/IAS 16 – Immobilizzazioni materiali | Manipolazione degli ammortamenti con sovrastima della vita utile del bene |
| OIC 17/IAS 24 – Bilancio consolidato/Parti correlate | Mancata contabilizzazione di operazioni infragruppo (fraudolent accounting) |
| OIC 29/IAS 8 – Cambiamenti dei principi contabili | Mancata comunicazione sulle variazioni degli standard setter adottati (da menzionare in nota integrativa(8)) |
| OIC 34/IFRS 15 – Ricavi | Fatturazione fittizia in assenza di trasferimento di rischi e benefici (fraudolent accounting) |
| IAS 20 – Contabilizzazione dei contributi pubblici ed informativa | Mancata comunicazione dei contributi pubblici ricevuti |
| OIC 12/IFRS 16 – Leasing | Metodo patrimoniale maggiormente vantaggioso (maggior ROI e minor PFN) rispetto allo standard internazionale |
Compreso quanto teste menzionato, è legittimo chiedersi a questo punto se una politica di Earnings Management discrezionale (e dunque lecita) sia in contrapposizione con quanto richiesto dallo standard setter nazionale/internazionale, ed in particolare:
- Dall’art. 2423 comma 2 del Codice civile già menzionato,
- Dal principio contabile nazionale 11 ed in particolare dal punto 6, nonché
- Dal principio contabile internazionale 1, ed in particolare da quanto enunciato dall’art. 1.2?
La risposta è negativa purché la suddetta politica non sia finalizzata all’income increasing; come si vedrà più avanti, qualora l’EM sia funzionale alla manipolazione dell’utile, violerebbe quanto già richiamato dal Codice civile e dai principi contabili nazionali ed internazionali, ed in particolare proprio dal principio della prudenza (postulato n°1 dell’OIC 11), generando il cosiddetto “falso valutativo”.
Una particolare attenzione, a detta del sottoscritto, va rivolta soprattutto a tre standard contabili nazionali, ovvero OIC 11, OIC 15 ed OIC 34: ribadita l’ovvia centralità della prudenza (il primo dei 7 postulati in ordine di elenco e di importanza(9), la manipolazione di ricavi e crediti comporta valori non veritieri e non corretti del Cash Flow Operativo.
Ricavi e crediti infatti sono componenti primarie del Net Working Capital (una componente del Cash Flow Operativo) e dell’EBITDA, due proxy particolarmente utilizzate in finanza aziendale: l’Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization in particolare, pur non essendo definito da alcun standard setter nazionale/internazionale (ma facilmente calcolabile col prospetto di conto economico civilistico), è un “indicatore finanziario e di performances”(10)”; questo infatti viene utilizzato tanto per la misurazione della performance economica quanto per la valutazione d’impresa, sia nel caso di operazioni straordinarie che nella valutazione del merito creditizio da parte degli istituti finanziatori.
Dando per assodate e conosciute le modalità di calcolo dell’EBITDA, è facilmente comprensibile come ogni operazione di EM finalizzata alla manipolazione dei ricavi e dei crediti (ovvero “income increasing”) ingenera un falso valutativo (più o meno marcato) ed opacizza il quadro d’insieme per colui che è chiamato a valutare le performances e la solvibilità dell’impresa.
È lapalissiano come, fintanto che l’impresa opera regolarmente, genera flussi positivi e adempie con puntualità alle obbligazioni contrarre, le politiche di EM discrezionali non generano potenziali esternalità negative; ma cosa accade nel caso in cui l’impresa diventa tecnicamente insolvente e le politiche di EM vengono inevitabilmente alla luce?
to be continued 1/3
Intervento di Cristiano ROMAGNOLI | Senior Corporate Relationship Manager in Illimity Bank
Link all’Articolo completo in formato pdf, Earnings Management nell’accesso al credito delle PMI e i profili di rischio-reato
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) Jensen, M.C. & Meckling, W.H., 1976. Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, vol.3 (4), 305-360.
(2) Schipper, K.,1989. Commentary on Earnings Management. Accounting Horizons, vol.3 (4), 91-102
(3) Haely, P.M. & Wahlen, J.M., 1999. A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting Horizons, vol.13 (4), 365-383.
(4) Verona R., Le politiche di bilancio. Motivazioni e riflessi economico-aziendali, Giuffrè Editore, Milano, 2006.
(5) Patricia M. Dechow and Douglas J. Skinner, Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, Michigan Business School, february 2000.
(6) Generally Accepted Accounting Principles, ovvero l’insieme di principi, standard e procedure contabili che le aziende devono seguire nella redazione dei bilanci finanziari.
(7) Introdotto dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.
(8) Principio contabile nazionale n. 29, Parr. 59 – 67.
(9) Principio contabile nazionale n. 11, par.15, lett. A).
(10) “EBITDA e PFN a fini valutativi e negoziali”, Documento di ricerca, Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili, marzo 2024.