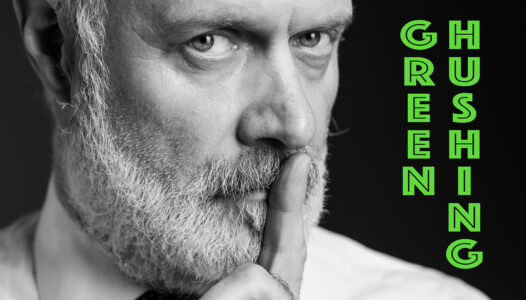di Marta VALENTINI
Con la legge di conversione del c.d. decreto “Terra dei Fuochi” (Legge 147/2025(1)) il legislatore torna a mettere mano alla disciplina dei reati ambientali.
L’operazione normativa si sviluppa lungo due direttrici principali.
Da un lato, vengono scomposte e rimodellate alcune condotte già note, che non sono più relegate al ruolo di semplici circostanze aggravanti, ma vengono trasformate in autonome fattispecie di reato. Dall’altro lato, si assiste a un progressivo abbandono dello schema tradizionalmente contravvenzionale, che ha a lungo caratterizzato il diritto penale dell’ambiente, a favore della qualificazione come delitti di numerose violazioni. Il combinato effetto di questi interventi è un marcato irrigidimento del trattamento sanzionatorio complessivo, pensato per rafforzare la tutela rispetto ai c.d. ecodelitti.
La riforma non si arresta però al versante della responsabilità delle persone fisiche, ma incide in modo significativo anche sulla responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001. In questo contesto, il legislatore ha infatti riorganizzato e ampliato il catalogo dei reati presupposto e inasprito l’apparato sanzionatorio applicabile.
Il presente contributo si propone di analizzare le principali novità introdotte dalla Legge 147/2025, con particolare riguardo proprio al loro impatto sulla gestione del rischio-reato ambientale nelle imprese, evidenziando le conseguenti ricadute sui modelli 231. Si tratta, evidentemente, di una materia ad elevato tasso di tecnicità, che richiederebbe analisi di ben maggiore ampiezza: le considerazioni che seguono hanno dunque natura selettiva ed intendono offrire soltanto alcuni spunti di riflessione operativa. L’esame sarà inoltre inserito nel più ampio quadro europeo tracciato dalla recente Direttiva (UE) 2024/1203(2) sulla tutela penale dell’ambiente, alla cui attuazione l’ordinamento italiano è chiamato nei prossimi mesi.
La nuova circostanza aggravante dell’attività di impresa o comunque organizzata
La consapevolezza che la criminalità ambientale sia radicata nelle filiere economiche e, non di rado, connessa alla criminalità organizzata ha indirizzato il legislatore verso opzioni di politica criminale volte a colpire soprattutto gli illeciti che si consumano nei contesti aziendali.
In questa prospettiva, la Legge 147 ha innanzitutto introdotto, all’art. 259 bis d.lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale, T.U.A.), una nuova aggravante che prevede l’aumento di un terzo della pena appunto quando “i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata”.
Non è mancato chi ha osservato (e criticato) come, in sede applicativa, sarà difficile perimetrare la nozione di “attività organizzata”, con il rischio di condurre la disposizione al limite dell’indeterminatezza: oltre ai casi in cui il reato abbia trovato la propria genesi e/o concretizzazione in un contesto organizzato di esercizio dell’attività di impresa, resta infatti da chiarire quando un minimo apporto di mezzi e risorse integri quel minimumorganizzativo idoneo a far scattare l’aggravante, anche in assetti rudimentali(3).
Va detto, comunque, che la circostanza non si applica all’intero T.U.A., ma soltanto ai reati di cui agli artt. 256 (gestione non autorizzata dei rifiuti, in tutte le declinazioni), 256 bis (combustione illecita) e 259 (spedizione illegale di rifiuti). Inoltre, rispetto al testo originario del decreto legge, la legge di conversione ha il merito di aver eliminato due profili critici, ossia:
- la responsabilità aggravata del titolare dell’impresa per “omessa vigilanza” “sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa”, che rischiava derive di responsabilità oggettiva o da posizione;
- l’applicabilità delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001 ai titolari o responsabili (come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 259 bis T.U.A.), soluzione di complessa tenuta sistematica se riferita alle persone fisiche e, comunque, in evidente tensione con l’assetto proprio della responsabilità degli ent(4).
Modifiche al d.lgs. 231/2001
Come anticipato, la riforma interviene direttamente anche sull’art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001 (rubricato “reati ambientali”). Da un lato, infatti, riorganizza il catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell’ente; dall’altro, inasprisce le cornici edittali dei corrispondenti illeciti amministrativi, coerentemente con l’impostazione punitiva della riforma.
Con riferimento al primo aspetto (catalogo dei reati presupposto), merita di essere innanzitutto segnalato il superamento di quella che, nella riforma del 2015, aveva rappresentato una significativa “dimenticanza” del legislatore: l’introduzione del delitto di omessa bonifica di cui all’art. 452 terdecies c.p., che sanziona “chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi”.
La fattispecie di omessa bonifica è infatti disciplinata da più disposizioni, che prevedono conseguenze diverse a seconda della gravità della violazione. In primo luogo, può integrare un reato contravvenzionale ai sensi dell’art. 257 T.U.A., quando si superano le soglie di rischio senza procedere agli interventi di bonifica conformemente a un progetto approvato. In secondo luogo, l’omessa bonifica può assumere rilievo come reato delittuoso ai sensi appunto del già citato art. 452 terdecies c.p., che punisce più gravemente il mancato adempimento di un obbligo di bonifica, ripristino o recupero.
Prima della riforma in esame, solo la contravvenzione di cui all’art. 257 TUA – e non anche il delitto di cui all’art. 452 terdecies c.p. – era ricompresa tra i reati presupposto della responsabilità dell’ente. Con la Legge 147 il legislatore ha sanato questa asimmetria, che portava al paradosso di sanzionare l’ente per fatti meno gravi, escludendo invece quelli più riprovevoli riconducibili alla fattispecie delittuosa di omessa bonifica.
Quanto alle ulteriori fattispecie – dovendo necessariamente operare una selezione non potendole qui trattare tutte – appare particolarmente rilevante l’attenzione riservata, ora anche sotto il profilo della responsabilità 231, ai rapporti con le Autorità di controllo. In tale prospettiva si colloca il delitto, in precedenza previsto solo per le persone fisiche, di impedimento del controllo, contemplato dall’art. 452 septies c.p., che incrimina chi, “negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”.
Si tratta, con ogni evidenza, di una disposizione che non si esaurisce nell’ambito delle imprese operanti nel settore dei rifiuti: il suo tenore letterale consente di ritenerla applicabile a ogni ipotesi in cui vengano ostacolati i controlli degli organi preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ne discende, per tutti gli enti, l’esigenza di dotarsi di misure organizzative e protocolli interni chiari, strutturati e pienamente tracciabili per la gestione delle ispezioni e, più in generale, dei rapporti con le Autorità di controllo.
Sul piano sanzionatorio, si registra, invece:
- un sensibile aumento delle quote per la sanzione pecuniaria di volta in volta applicabile; in alcuni passaggi (art. 25 undecies, comma 1, lett. e), e comma 2, lett. b), n. 3 ter, riferiti rispettivamente al traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e a talune ipotesi di gestione di rifiuti non autorizzata) la forchetta “da 600 a 1.200 quote” risulta addirittura andare oltre quanto previsto dalla disciplina generale contenuta nell’art. 10, comma 2, d.lgs. 231/2001, per cui “la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille”;
- l’introduzione di sanzioni interdittive anche definitive ex art. 16 del d.lgs. 231 se l’ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di taluni ecoreati(5).
In sede di conversione, la Legge 147 ha inoltre integrato l’art. 34, comma 1, d.lgs. 159/2011 (Codice antimafia), inserendo un secondo periodo che stabilisce che, quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di attività economiche possa agevolare l’attività di persone sottoposte a procedimento penale per taluni reati ambientali, la proposta di applicazione dell’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni può essere formulata anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario la persona dimora(6).
Per gli operatori economici ciò impone un rafforzamento dei controlli formali e sostanziali lungo l’intera filiera; ciò al fine di scongiurare l’agevolazione colposa dell’altrui illecito, con rischio di sottoposizione dell’azienda ad amministrazione giudiziaria e possibile paralisi, anche totale, dell’attività. In questa prospettiva, l’ente deve operare una due diligence preventiva e continuativa, verificando, ad esempio, che fornitori e sub-fornitori siano qualificati e operino nel rispetto della normativa ambientale e che non abbiano precedenti sanzionatori.. Al contempo, l’inserimento di clausole di salvaguardia 231 nei contratti con i terzi consente di attribuire loro specifici obblighi di compliance e relative conseguenze civilistiche in caso di violazione, estendendo così anche ai soggetti esterni il sistema disciplinare richiesto dall’art. 6, comma 2, lett. e), d.lgs. 231/2001. Risulta altresì opportuno prevedere e svolgere controlli operativi, anche mediante sopralluoghi periodici presso gli impianti principali e nei confronti dei trasportatori strategici.
Legge 142 e Direttiva UE 2024/1203: repressione penale e ruolo della “green compliance”
La Legge 142, pur con qualche correzione, conferma sostanzialmente l’impianto repressivo del decreto legge da cui origina, nella convinzione che l’inasprimento della risposta penale sia di per sé un deterrente sufficiente. Resta discutibile se, per tempi e modalità, un intervento così urgente fosse davvero necessario.
Il ricorso allo strumento del decreto-legge è stato formalmente motivato con l’esigenza di rafforzare il contrasto ai reati in materia di rifiuti su tutto il territorio nazionale – con specifico riferimento al fenomeno della Terra dei fuochi e ai roghi tossici che mettono a rischio salute e ambiente – nonché di dare esecuzione alla sentenza della CEDU Cannavacciuolo e altri c. Italia (30 gennaio 2025)(7), che ha accertato la violazione dell’art. 2 (diritto alla vita) della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU)(8) da parte dello Stato italiano(9).
Va tuttavia rilevato che la Corte EDU ha concesso all’Italia un termine di due anni (entro il 2027) per l’adozione di misure preventive e repressive adeguate. In questa prospettiva, non risulta chiara la ragione per cui si sia ritenuto necessario intervenire mediante decreto-legge, invocando i presupposti della straordinaria necessità e urgenza indicati dall’art. 77 Costituzione(10).
Parallelamente, la riforma si inserisce – pur in maniera implicita – nel percorso di recepimento della Direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente(11), per la quale la Legge 91/2025(12) ha in realtà già fissato principi attuativi in vista della scadenza del 21 maggio 2026.
Risulta, dunque, ancor meno comprensibile la scelta di intervenire con un decreto-legge ad hoc. Per di più, la riforma dedicata alla Terra dei Fuochi è ispirata da una marcata opzione repressiva, che privilegia l’inasprimento degli strumenti sanzionatori. Un’impostazione che si pone in contrasto con lo spirito della Direttiva europea, la quale affianca agli strumenti punitivi un altrettanto chiaro e strutturato versante preventivo, imperniato su una gestione del rischio ambientale orientata in chiave anticipatoria.
Infatti la Direttiva, oltre a imporre la criminalizzazione di specifiche condotte(13), delinea un modello di responsabilità degli enti parzialmente allineato alla logica del d.lgs. 231/2001 e ai relativi criteri di imputazione oggettiva e soggettiva. In essa si rinvengono, infatti, le nozioni di reato presupposto, di soggetto agente qualificato (in posizione apicale o subordinata), di vantaggio per l’ente e di colpa per insufficiente attività di vigilanza o controllo (art. 6)(14). Sono inoltre previste sanzioni accessorie “riparative”, finalizzate al recupero alla legalità dell’ente più che alla sola afflizione, come la sorveglianza giudiziaria e l’obbligo di prevedere sistemi di dovuta diligenza (“due diligence”) ambientale (art. 7, comma 2, lett. f) ed i))(15).
La Direttiva valorizza dunque la compliance – in particolare la “green compliance” – come strumento di prevenzione e riparazione, sollecitando l’Italia e gli altri paesi UE non solo a rafforzare il versante repressivo, ma anche a incentivare in maniera proattiva l’adozione di sistemi efficaci di gestione del rischio reato in seno alle aziende.
E’ emblematico, in tal senso, il considerando n. 59, secondo cui è opportuno che gli Stati Membri adottino “campagne di informazione e sensibilizzazione …, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali in generale e il rischio di criminalità ambientale”; agiscano “in cooperazione con [i]portatori di interessi”; promuovano “sistemi di conformità e di dovuta diligenza”, anche attraverso “l’incoraggiamento degli operatori a dotarsi di responsabili della conformità che contribuiscano a garantire il rispetto del diritto ambientale dell’Unione e la promozione della trasparenza al fine di rafforzare il rispetto del diritto penale ambientale”.
Il ruolo di impulso e supporto richiesto agli Stati Membri dell’Unione europea diventa particolarmente rilevante in un contesto imprenditoriale come quello italiano, dominato da piccole e medie imprese (PMI), che spesso non dispongono delle risorse per adottare in autonomia e senza alcun supporto sistemi complessi di gestione del rischio legato agli ecoreati.
L’intervento degli Stati è richiesto anche in relazione al c.d. “speak up“, ovvero alla promozione e tutela di coloro che denunciano (in questo caso) gli ecoreati declinati dalla Direttiva. Oltre a garantire la protezione del segnalante, gli Stati Membri sono chiamati a implementare misure che incentivino la segnalazione, offrendo tutele adeguate per chi si fa avanti (come l’accesso a misure di sostegno e l’assistenza nel procedimento penale), favorendo così la trasparenza e la responsabilità all’interno delle organizzazioni(16). Si tratta, ovviamente, di provvedimenti che andranno coordinati nel contesto più ampio della normativa sul whistleblowing, anch’essa di matrice unionale e disciplinata, nel caso dell’ordinamento italiano, dal d.lgs. 24/2023.
Considerato lo spirito e i tempi di recepimento della Direttiva (2026), sarebbe stato auspicabile, ad opinione di chi scrive, un confronto tecnico e parlamentare più ampio, che avrebbe potuto portare a una disciplina più equilibrata: non solo orientata alla punizione, ma capace di promuovere effettivamente meccanismi di prevenzione basati su una compliance concreta ed efficace. Sarà ora compito delle imprese cogliere l’opportunità per ripensare i propri sistemi di gestione del rischio ambientale, valorizzando il modello 231 come strumento chiave della “green compliance” per minimizzare al meglio il rischio di commissione degli ecoreati(17).
Intervento di Marta VALENTINI, Avvocato, Studio Legale Pellegrino
Per approfondimenti, consultare i seguenti link e/o riferimenti:
(1) Legge 3 ottobre 2025, n. 147, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”. Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2025.
(2) Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.
(3) Tra gli ultimi, M. Riccardi, “«Chi inquina paga, senza sconti». Il decreto legge “Terra dei fuochi”: una riforma “di sistema” del diritto penale dell’ambiente, mascherata da riforma di settore (in attesa del recepimento della direttiva (UE) 2024/1203)”, in Giurisprudenza Penale web, 2025, 9, pp. 24-25.
(4) La formulazione dell’aggravante riprendeva quella della previgente disposizione dell’articolo 256 bis, comma 3, primo periodo T.U.A. in tema di combustione illecita di rifiuti, ora abrogata.
(5) L’interdizione definitiva, stante l’effetto di totale annichilimento dell’ente che è destinata a produrre, è prevista in riferimento alle sole ipotesi – ritenute più gravi – in cui l’ente (o parte di esso) è “strumentalizzato” ai fini della commissione dei delitti di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), di disastro ambientale (art. 452 quater c.p.), di traffico di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.), di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.), delle varie fattispecie di gestione abusiva di rifiuti (art. 256 d.lgs. 152/2006), dei delitti di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis d.lgs. 152/2006) e di spedizione illegale di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006), nonché della contravvenzione di inquinamento navale doloso (art. 8 d.lgs. 202/2007). Si osserva, in proposito, che la previsione, se da un lato risulta del tutto innovativa nella comminatoria dell’interdizione definitiva per alcuni ecodelitti e per i principali delitti in materia di rifiuti, dall’altro determina una palese ridondanza normativa dal momento che il successivo comma 8, il quale non risulta contestualmente abrogato dal decreto legge, già dispone analoga sanzione per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) e per la contravvenzione di inquinamento navale doloso (art. 8 d.lgs. 202/2007).
(6) In particolare, è oggi possibile applicare tale misura di prevenzione anche nei confronti di enti che si ritiene, sulla base di sufficienti indizi, agevolino l’attività di soggetti sottoposti a procedimento penale per: Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.); abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter d.lgs. 152/2006); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (limitatamente alle ipotesi previste dall’art. 256, commi 1, secondo periodo, 1 bis, 3 e 3 bis, d.lgs. 152/2006); combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis d.lgs. 152/2006); spedizione illegale di rifiuti (art. 259 d.lgs. 152/2006).
(7) La sentenza CEDU Cannavacciuolo e altri c. Italia è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia, al seguente link: www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1455751.
(8) Art. 2 (Diritto alla vita): “Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione”.
(9) Secondo le indicazioni dello stesso decreto legge, l’urgenza si fondava, in particolare, su un duplice ordine di ragioni (in termini di straordinaria necessità e urgenza): i) “assicurare il contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti, che interessano l’intero territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree della c.d. “Terra dei fuochi””; ii) “contrastare il fenomeno dei roghi tossici di rifiuti urbani e speciali che mettono in pericolo la vita e l’incolumità delle persone, compromettendo altresì la salubrità dell’ambiente”.
(10) Art. 77 Cost.: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
(11) Il testo della Direttiva è consultabile su EurLex, al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401203.
(12) Legge 13 giugno 2025, n. 91 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2024”. Gazzetta Ufficiale n.145 del 25 giugno 2025. In particolare, l’art. 9 prevede i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega da parte del Governo tra cui (i) definizione dei reati e delle relative aggravanti/attenuanti e previsione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per tali reati (comma 1, lett. a)); (ii) introduzione, per le persone giuridiche, di sanzioni o misure—penali o non penali—parimenti effettive, dissuasive e proporzionate (comma 1, lett. b)).
(13) Cfr. artt. 3 e 4 della Direttiva, dedicati rispettivamente ai “reati” e ai casi di “istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo”.
(14) L’art. 6 della Direttiva, rubricato “Responsabilità delle persone giuridiche”, individua quale criterio oggettivo di imputazione all’ente il “vantaggio” (art. 6, comma 1) ottenuto tramite la commissione di un reato ambientale da parte di “qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica interessata”. Tale posizione è specificata – singolarmente o quale componente di un organo – nel “potere di rappresentanza”, nel “potere di decisione per conto della persona giuridica” e nel “potere di controllo in seno alla persona giuridica”. È evidente il richiamo alla nozione di soggetti apicali di cui all’art. 5 del d.lgs. 231/2001. L’eco del d.lgs. 231 si ritrova anche per i soggetti sottoposti all’altrui direzione (art. 7, d.lgs. 231/2001): il comma 2 dell’art. 6 stabilisce che “le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo” di uno degli apicali sopra menzionati “abbia reso possibile la commissione di un reato […] a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità”. Pur evocando profili di responsabilità vicariale per omesso impedimento, emerge la relazione qualificata apicale/sottoposto nella governance ai fini della commissione – e dunque della prevenzione – del reato d’impresa, con riflessi autonomi sul sistema sanzionatorio dell’ente. Infine, il comma 3 dell’art. 6 precisa che la responsabilità dell’ente “non preclude l’azione penale” verso le persone fisiche che commettono, istigano o concorrono nei reati previsti, introducendo un principio di indipendenza tra accertamento della responsabilità corporativa e individuale che, in sede di recepimento, dovrà coordinarsi con l’autonomia della responsabilità dell’ente sancita dall’art. 8 d.lgs. 231/2001.
(15) Il concetto di “dovuta diligenza” interessa anche la fase di gestione del rischio, laddove il considerando n. 59 specifica che “Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore sia pubblico sia privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali in generale e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero agire in cooperazione con tali portatori di interessi. In tale contesto, le misure volte a migliorare la prevenzione dei reati ambientali potrebbero includere la promozione di sistemi di conformità e di dovuta diligenza, l’incoraggiamento degli operatori a dotarsi di responsabili della conformità che contribuiscano a garantire il rispetto del diritto ambientale dell’Unione e la promozione della trasparenza al fine di rafforzare il rispetto del diritto penale ambientale. Inoltre, le sanzioni accessorie inflitte alle persone giuridiche ai sensi della presente direttiva potrebbero Gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate, quali campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai pertinenti portatori di interessi del settore sia pubblico sia privato, nonché programmi di ricerca e istruzione, che mirano a ridurre i reati ambientali in generale e il rischio di criminalità ambientale. Se del caso, gli Stati membri dovrebbero agire in cooperazione con tali portatori di interessi. In tale contesto, le misure volte a migliorare la prevenzione dei reati ambientali potrebbero includere la promozione di sistemi di conformità e di dovuta diligenza, l’incoraggiamento degli operatori a dotarsi di responsabili della conformità che contribuiscano a garantire il rispetto del diritto ambientale dell’Unione e la promozione della trasparenza al fine di rafforzare il rispetto del diritto penale ambientale. Inoltre, le sanzioni accessorie inflitte alle persone giuridiche ai sensi della presente direttiva potrebbero”.
(16) Art. 14 della Direttiva (Protezione delle persone che segnalano reati ambientali o che prestano assistenza nelle relative indagini): “Fatta salva la direttiva (UE) 2019/1937, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque segnali i reati di cui agli articoli 3 e 4 della presente direttiva e fornisca elementi di prova o collabori in altro modo con le autorità competenti, abbia accesso a misure di sostegno e assistenza nel contesto del procedimento penale, conformemente al diritto nazionale”.
(17) Il Modello 231 può assumere una funzione trasversale nella tutela dell’ambiente, contribuendo anche al perseguimento degli obiettivi ESG. Per un approfondimento sulla possibilità di instaurare un rapporto integrato tra sistema di gestione del rischio 231 e obiettivi di sostenibilità, v. F. Dottore – M. Valentini, “Sostenibilità e sistema di gestione del rischio reato ex D.Lgs. 231/2001”, in Costantino – Capo, I Principi ESG e di sostenibilità, Lefebvre Giuffrè, 2025